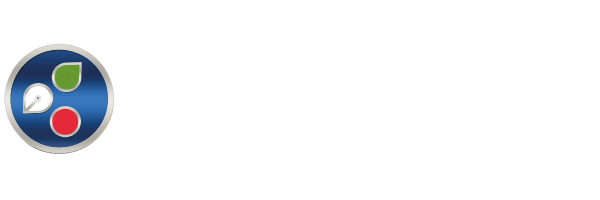Dissonanze
Nella musica il concetto di dissonanza esiste da sempre. Nel vino, in antico, le dissonanze derivavano dalle procedure poco ortodosse e si cercava di correggerle magari con le spezie. Oggi, in qualche caso, le dissonanze vengono addirittura cercate.
Pubblicato il 28/02/2017
 Nella musica il concetto di dissonanza, contrapposto a quello di consonanza, esiste da sempre. Sin dal tardo medioevo, con la musica corale (canti gregoriani), la tendenza è stata quella di cercare di risolvere la dissonanza, circondandola di accordi consonanti non troppo dissimili. La creazione della dissonanza, in realtà, è un processo fisico piuttosto complicato che ha raccolto molteplici interventi, incluso quello semplicistico di Galileo, secondo il quale la dissonanza è direttamente proporzionale al periodo del suono complessivo, per analogia con la consonanza che si comporta nello stesso modo. Bisogna attendere, però, la seconda metà dell’ottocento per comprendere, con gli esperimenti di Hermann Helmholtz (1821-1894), come l’origine fisica della dissonanza si trovasse interamente nei battimenti, cioè nelle variazioni periodiche dell'ampiezza massima dell'onda risultante dalla sovrapposizione di due onde con frequenza diversa. Semplice, no? Al di là della teoria fisica, fu però il fermento culturale del Romanticismo, in contrapposizione all’Illuminismo, a mettere in discussioni i capisaldi dell’armonia musicale. Celebre è divenuto l’accordo iniziale di Tristano e Isotta di Wagner (1856-1859), (Tristano e Isotta Preludio), che rompe gli schemi del sistema tonale sino ad allora utilizzato, aprendo le porte alla ricerca della dissonanza. Nei primi del ‘900 Debussy fondò il proprio successo sulla scala esatonale ed altri espedienti extratonali, pur mantenendo una rigida proporzione nel componimento: La Mer (Debussy La Mer). Lo schema tonale viene definitivamente abbandonato quando nel 1923 Arnold Schoemberg, con l’articolo Komposition mit 12 Tönen, di fatto lancia la musica dodecafonica, ben espressa nelle Premonizioni op. 16 (Schoemberg premonizioni), in cui la dissonanza trionfa e diventa ricerca di una maggiore ricchezza polifonica. La musica dodecafonica è poi sfociata nella “serialità integrale” prima con Artur Webern e poi con Pierre Boulez (Pierre Boulez, Structures I & II).
Nella musica il concetto di dissonanza, contrapposto a quello di consonanza, esiste da sempre. Sin dal tardo medioevo, con la musica corale (canti gregoriani), la tendenza è stata quella di cercare di risolvere la dissonanza, circondandola di accordi consonanti non troppo dissimili. La creazione della dissonanza, in realtà, è un processo fisico piuttosto complicato che ha raccolto molteplici interventi, incluso quello semplicistico di Galileo, secondo il quale la dissonanza è direttamente proporzionale al periodo del suono complessivo, per analogia con la consonanza che si comporta nello stesso modo. Bisogna attendere, però, la seconda metà dell’ottocento per comprendere, con gli esperimenti di Hermann Helmholtz (1821-1894), come l’origine fisica della dissonanza si trovasse interamente nei battimenti, cioè nelle variazioni periodiche dell'ampiezza massima dell'onda risultante dalla sovrapposizione di due onde con frequenza diversa. Semplice, no? Al di là della teoria fisica, fu però il fermento culturale del Romanticismo, in contrapposizione all’Illuminismo, a mettere in discussioni i capisaldi dell’armonia musicale. Celebre è divenuto l’accordo iniziale di Tristano e Isotta di Wagner (1856-1859), (Tristano e Isotta Preludio), che rompe gli schemi del sistema tonale sino ad allora utilizzato, aprendo le porte alla ricerca della dissonanza. Nei primi del ‘900 Debussy fondò il proprio successo sulla scala esatonale ed altri espedienti extratonali, pur mantenendo una rigida proporzione nel componimento: La Mer (Debussy La Mer). Lo schema tonale viene definitivamente abbandonato quando nel 1923 Arnold Schoemberg, con l’articolo Komposition mit 12 Tönen, di fatto lancia la musica dodecafonica, ben espressa nelle Premonizioni op. 16 (Schoemberg premonizioni), in cui la dissonanza trionfa e diventa ricerca di una maggiore ricchezza polifonica. La musica dodecafonica è poi sfociata nella “serialità integrale” prima con Artur Webern e poi con Pierre Boulez (Pierre Boulez, Structures I & II).Una volta liberata dagli schemi, la dissonanza non si è più fermata, è stata cercata, sperimentata, amata, odiata, ha contribuito a creare nuove armonie, così come a demolirne altre. È fuor di dubbio, in ogni caso, che abbia segnato in maniera indelebile il percorso musicale degli ultimi cento anni. Oltre a permanere nella musica contemporanea, per la quale cito solo il visionario Michael Nyman, autore di mitiche colonne sonore, (SPARK Michael Nyman An Eye for Optical Theory), ha sedotto tutti i generi musicali. Il jazz è stata la prima vittima, e non solo nel suo periodo cool, con Stan Getz e Chet Baker (Chet Baker & Stan Getz - Haig '53), passando per Miles Davis (The Best Of Miles Davis) per finire con i Weather Report (Weather Report - Heavy Weather). Il rock, con la sua volontà di rompere gli schemi, ne ha fatto una bandiera, sin dalle origini, come in “Lucy in the sky with diamond” dei Beatles (Lucy in the sky with diamond); per svilupparsi, poi, nelle sonorità psichedeliche dei Doors, qui in Light my fire (Light my fire); in quelle acide con Jimi Hendrix nella sua libera interpretazione dell’inno americano a Woodstock (The Star Spangled Banner American Anthem); in quelle elettroniche: Tarkus degli Emerson Lake & Palmer l’esempio più eclatante (Tarkus). La musica elettronica è interamente fondata sulla dissonanza a cominciare dai Tangerine Dream con la loro musica cosmica, questa è Alpha Centauri del 1971 (Alpha Centauri Tangerine Dream) per continuare in tutte le sue declinazioni attuali, ben definite dalla rassegna che si è svolta a Roma, con cadenza annuale dal 2000 al 2010, e che alle “Dissonanze” è stata interamente dedicata (Richie Hawtin live Dissonanze 2010); senza dimenticare Meet in Town, sempre a Roma all’Auditorium (Meet in Town). Infine, fuori dagli schemi, inclusi quelli della musica popolare da cui trae origine, non poteva mancare in questo inno alla dissonanza Goran Bregovic con la sua Karmen (Karmen Bregovic).
 La similitudine tra il percorso del vino e quello della musica è impressionante. Non abbiamo notizie certe sull’origine della musica, intesa come “produzione di suoni per mezzo di strumenti appositamente creati”, ma gli studi antropologici fanno facilmente desumere una nascita casuale dovuta alla percussione di elementi di origine vegetale per infondere ritmo alle prime manifestazioni rituali. Questo avveniva all’inizio del paleolitico superiore, più o meno cinquantacinquemila anni fa, in Africa, durante la prima fase migratoria dell’uomo. Per incontrare un vero e proprio “sistema teorico di organizzazione dei suoni e rumori nel corso del tempo e nello spazio” bisogna attendere, però, la Grecia classica. Infatti, a questo periodo, tra il VI e il IV secolo a.C., risalgono le prime testimonianze di scrittura musicale. Da qui in poi, come abbiamo visto, le dissonanze furono aspramente combattute fino alla fine del XIX secolo.
La similitudine tra il percorso del vino e quello della musica è impressionante. Non abbiamo notizie certe sull’origine della musica, intesa come “produzione di suoni per mezzo di strumenti appositamente creati”, ma gli studi antropologici fanno facilmente desumere una nascita casuale dovuta alla percussione di elementi di origine vegetale per infondere ritmo alle prime manifestazioni rituali. Questo avveniva all’inizio del paleolitico superiore, più o meno cinquantacinquemila anni fa, in Africa, durante la prima fase migratoria dell’uomo. Per incontrare un vero e proprio “sistema teorico di organizzazione dei suoni e rumori nel corso del tempo e nello spazio” bisogna attendere, però, la Grecia classica. Infatti, a questo periodo, tra il VI e il IV secolo a.C., risalgono le prime testimonianze di scrittura musicale. Da qui in poi, come abbiamo visto, le dissonanze furono aspramente combattute fino alla fine del XIX secolo.La nascita del vino, pur se ugualmente casuale, viene fatta risalire a qualche millennio dopo, anche se è presumibile che un primordiale succo fermentato di vitis vinifera sylvestris fosse conosciuto anche ai primi Homo Sapiens. Bisogna attendere però l’inizio del Neolitico, circa diecimila anni fa, per avere, con la domesticazione di piante e animali per uso commestibile, le prime testimonianze dell’uso di strumenti per la riproduzione del fenomeno della fermentazione spontanea. Parlare in questo momento storico di dissonanze è quantomeno eufemistico: lo spunto acetico regnava sovrano su fermentazioni intermittenti, schiave delle oscillazioni termiche. Dopo settemila anni di sperimentazioni, con l’avvento della civiltà greca, si giunse alla definizione di un sistema teorico di organizzazione di strumenti e materie prime, nel corso del tempo e nello spazio, per produrre e conservare il vino. Ha inizio così la lunga lotta contro le dissonanze, dapprima combattute con gli stessi strumenti usati nella musica, cioè “cercando di risolvere la dissonanza, circondandola di accordi consonanti non troppo dissimili”. Il concetto di “non troppo dissimili” non fu però preso in grande considerazione e forse è meglio dire che le dissonanze furono ammantate con aromatiche armonie ed esuberanti dolcezze. Ancora oggi, ad esempio, è facile trovare e assaggiare in Grecia il Retsina, il vino prodotto mediante l’aromatizzazione del mosto con resina di pino. I romani in seguito diventarono maestri in questa arte di avvolgere le dissonanze con ogni tipo di edulcorante. Il “vinum mulsum” era prodotto con l’inserimento del miele nel mosto, questo modo si aumentava il grado zuccherino, con il duplice scopo di addolcire la dissonanza e incrementare il grado alcolico. Nel tentativo di contenere gli effetti di procedure non proprio ortodosse e, quindi, per armonizzarne le conseguenti dissonanze, non veniva risparmiato l’utilizzo di spezie come pepe, cannella e chiodi di garofano; frutta secca, in particolare mandorle; frutta fresca per una primordiale sangria; aromi vegetali, dal muschio ai fiori e alle essene profumate; additivi come cenere, acqua di mare e residui animali. I romani ebbero il merito anche di introdurre strumenti atti a migliorare i processi di vinificazione e a contenere le dilaganti dissonanze. Le “dolia”, i tini di fermentazione in terracotta da circa duemila litri, furono interrati ottenendo, così, un parziale controllo delle temperature. I vini più pregiati, inoltre, venivano posti in anfore sigillate per poter invecchiare più a lungo, come testimonia il “Falernum Opinianum annorum centum” servito durante la “Cena Trimalchionis” nell’omonimo episodio del Satyricon di Petronio.
Nel medioevo imperavano vini dolci e vini frizzanti. Entrambi erano frutto di fermentazioni incomplete che lasciavano consistenti residui zuccherini pronti, con l’innalzamento delle temperature in primavera, a generare, in combutta con i lieviti non filtrati, anidride carbonica all’interno della bottiglia. In questi casi la dissonanza creata dall’errato processo è diventata, con il tempo, lo strumento attraverso il quale cercare la consonanza, attenuando l'effetto di asprezza provocato dalla dissonanza stessa. In sostanza si è riusciti a creare, come nella musica “un ambiente accordale consonante e non troppo dissimile”. Così, in modo totalmente empirico e spinto soprattutto dall’esigenza di non far scoppiare troppe bottiglie in cantina, Dom Perignon codificava la rifermentazione in bottiglia, peraltro già ampiamente sperimentata sull’altro lato della Manica dai potenti distributori inglesi. Madame Barbe Nicole Ponsardin, vedova Clicquot, inventava il remuage; nel 1865 Bollinger, dopo diversi insuccessi di suoi colleghi, riesciva a soddisfare la richiesta dei commercianti inglesi, spedendo a Londra una partita di Champagne very dry; alla fine dell’ottocento, infine, il botanico Emil Christian Hansen riuscì ad isolare e riprodurre due diversi ceppi di lieviti, grazie ai quali si è ottenuta una costanza qualitativa della rifermentazione in bottiglia. In duecento anni le dissonanze dei vini di Champagne, rappresentate da eccessiva acidità, intensa sapidità e rifermentazioni dovute alle basse temperature della zona, furono armonizzate nel contesto consonante, pur se “non troppo dissimile”, che è rappresentato dallo Champagne moderno. Contemporaneamente lo stesso identico percorso veniva intrapreso, sempre per volere degli onnipotenti mercanti inglesi, dai vini fortificati. Attraverso processi di ossidazione controllata, cottura, inserimento di distillati o mistelle, i vini venivano avvolti in un “ambiente consonante non troppo dissimile”, che li rendeva idonei ai lunghi viaggi per mare cui venivano sottoposti per soddisfare le esigenze della flotta britannica. Prima il Porto, poi lo Xeres, il Madeira e infine il Marsala vennero “armonizzati”, divenendo così, da vini poveri e popolari, preziosi depositari dell’eternità enologica.
Sempre nel XIX secolo, grazie agli studi di Pasteur, la lotta alle dissonanze del vino divenne “scientifica” e alcune scoperte rivoluzionarono le tecniche di vinificazione. Lieviti selezionati, controllo delle temperature, aggiunta di anidride solforosa e altri infiniti strumenti hanno permesso all’uomo di controllare ogni singola fase del processo di produzione del vino, azzerando tutte le dissonanze che il processo stesso tendeva a creare. Con Emile Peynaud, in Francia, e con il suo allievo Giacomo Tachis, in Italia, la vittoria dell’armonia sulla dissonanza fu definitiva. La riduzione delle rese in uva per pianta, la ricerca del punto di perfetta maturazione in vigna, la miscelazione di vini di provenienza diversa, l’utilizzo della barrique nuova, unitamente alle precedenti scoperte, resero possibile la creazione di vini dall’immediato equilibrio e dalla durata infinita. Iniziò cosi il lungo periodo della “costanza della qualità”: il vino doveva mantenere elevatissimi standard qualitativi e medesimo profilo gusto olfattivo a prescindere dagli agenti esterni. Questa filosofia produttiva, che raggiunse il suo apice negli anni ottanta, pur avendo il merito di aver elevato notevolmente il livello qualitativo dei vini medi, condusse inevitabilmente verso l’omologazione del prodotto vino. Come era accaduto un secolo prima per la musica, anche in campo enologico la ricerca della novità è diventato un imperativo commerciale. La dissonanza, precedentemente sconfitta, cominciò a farsi strada nelle aspettative del pubblico. Sempre come per la musica, questa esigenza fu inizialmente prerogativa di un’elite culturale per poi divenire fenomeno di massa. Si inizia, così, a recuperare vitigni autoctoni, precedentemente abbandonati in nome della quantità, in alcuni casi, o della qualità in altri. Biologico prima e biodinamico poi si diffondono sempre di più in nome della tutela ambientale e della salute del consumatore. I vini tendono a tornare “naturali”, la polemica si fa sempre più aspra: da una parte i sostenitori del “vino si fa in cantina, in vigna si fa l’uva”, dall’altra chi, invece sostiene che il “il vino si fa in vigna, in cantina si accompagna il lavoro che fa la natura”. Nuovi termini, che descrivono vecchie usanze, come inerbimento, sovescio, lieviti indigeni, fermentazioni spontanee, volatile, conquistano la ribalta del mondo del vino. Alla voglia di sperimentare del pubblico risponde, inevitabilmente, quella di soddisfare le esigenze del nuovo mercato da parte dei produttori. “Alea iacta est” è impossibile tornare indietro, le dissonanze stanno conquistando il mondo del vino, hanno creato nuove armonie. La scala timbrica dell’equilibrio armonico è stata scomposta e rimontata, come in un’opera di Maurits Cornelis Escher, secondo figurazioni impossibili che, mantenendo proporzioni perfette, creano una armonia altra che tende all’infinito.
Sempre nel XIX secolo, grazie agli studi di Pasteur, la lotta alle dissonanze del vino divenne “scientifica” e alcune scoperte rivoluzionarono le tecniche di vinificazione. Lieviti selezionati, controllo delle temperature, aggiunta di anidride solforosa e altri infiniti strumenti hanno permesso all’uomo di controllare ogni singola fase del processo di produzione del vino, azzerando tutte le dissonanze che il processo stesso tendeva a creare. Con Emile Peynaud, in Francia, e con il suo allievo Giacomo Tachis, in Italia, la vittoria dell’armonia sulla dissonanza fu definitiva. La riduzione delle rese in uva per pianta, la ricerca del punto di perfetta maturazione in vigna, la miscelazione di vini di provenienza diversa, l’utilizzo della barrique nuova, unitamente alle precedenti scoperte, resero possibile la creazione di vini dall’immediato equilibrio e dalla durata infinita. Iniziò cosi il lungo periodo della “costanza della qualità”: il vino doveva mantenere elevatissimi standard qualitativi e medesimo profilo gusto olfattivo a prescindere dagli agenti esterni. Questa filosofia produttiva, che raggiunse il suo apice negli anni ottanta, pur avendo il merito di aver elevato notevolmente il livello qualitativo dei vini medi, condusse inevitabilmente verso l’omologazione del prodotto vino. Come era accaduto un secolo prima per la musica, anche in campo enologico la ricerca della novità è diventato un imperativo commerciale. La dissonanza, precedentemente sconfitta, cominciò a farsi strada nelle aspettative del pubblico. Sempre come per la musica, questa esigenza fu inizialmente prerogativa di un’elite culturale per poi divenire fenomeno di massa. Si inizia, così, a recuperare vitigni autoctoni, precedentemente abbandonati in nome della quantità, in alcuni casi, o della qualità in altri. Biologico prima e biodinamico poi si diffondono sempre di più in nome della tutela ambientale e della salute del consumatore. I vini tendono a tornare “naturali”, la polemica si fa sempre più aspra: da una parte i sostenitori del “vino si fa in cantina, in vigna si fa l’uva”, dall’altra chi, invece sostiene che il “il vino si fa in vigna, in cantina si accompagna il lavoro che fa la natura”. Nuovi termini, che descrivono vecchie usanze, come inerbimento, sovescio, lieviti indigeni, fermentazioni spontanee, volatile, conquistano la ribalta del mondo del vino. Alla voglia di sperimentare del pubblico risponde, inevitabilmente, quella di soddisfare le esigenze del nuovo mercato da parte dei produttori. “Alea iacta est” è impossibile tornare indietro, le dissonanze stanno conquistando il mondo del vino, hanno creato nuove armonie. La scala timbrica dell’equilibrio armonico è stata scomposta e rimontata, come in un’opera di Maurits Cornelis Escher, secondo figurazioni impossibili che, mantenendo proporzioni perfette, creano una armonia altra che tende all’infinito.

A rappresentare questo lungo cammino comune delle dissonanze musicali ed enologiche potevano essere chiamati migliaia di possibili abbinamenti, molti dei quali avrebbero sicuramente espresso meglio le filosofie che hanno condotto alla scoperta di un mondo nuovo in gran parte ancora da esplorare. Questa esplorazione, proprio perché varca i confini del conosciuto, spesso sfocia, inevitabilmente, negli eccessi insiti nella sperimentazione. Sia per la musica sia per il vino ho cercato, quindi, tra quelle espressioni che, pur rappresentando la modernità della dissonanza riconquistata, avessero già raggiunto la classicità. Per quanto riguarda la musica mi sono orientato verso il progressive rock britannico, scegliendo quelli che ne vengono considerati i padri: i Pink Floyd. Nati a metà degli anni sessanta divennero in poco tempo una delle massime espressioni del rock psichedelico di oltremanica. La voglia irrefrenabile di esplorare e di sperimentare, in studio come sul palco, nella grafica delle proprie copertine, così come nell’illuminazione dei propri concerti, li condusse oltre i confini di una categorizzazione precisa. Lo studio delle dissonanze è stato parte integrante di questo lavoro, che ancora continua dopo cinquant’anni di onorata carriera. Questa tenacia assomiglia molto a quella che ha caratterizzato il lungo lavoro di vignaioli che, esplorando e sperimentando, hanno cercato di addomesticare le dissonanze nel vino, senza privarle delle loro potenzialità espressive, cercando di valorizzare, attraverso di esse, la complessità del profilo armonico del vino. La scelta è quindi caduta su uno dei loro brani che sulla dissonanza ha fondato il proprio successo, che dura dal lontano 1973, anno in cui uscì il disco di cui fa parte, The Dark Side of the Moon: Money live, qui nella versione live tratta da Delicate Sound of Thunder, disco registrato nel 1988 al Nassau Coliseum di Long Island.
Money disco, qui invece nella versione originale registrata in studio.
The Dark Side of the Moon, con oltre quarantacinque milioni di copie, è il quarto disco più venduto di sempre. Nacque, in parte, durante il tour di presentazione di Meedle del 1971, fu perfezionato nel corso dell’omonimo tour, che debuttò al Rainbow Theatre di Londra il 17 gennaio del 1972. L’album fu infine registrato in due sessioni nel 1972 e nel 1973, agli Abbey Road Studios di Londra, e rappresenta l’apice della sperimentazione del gruppo. I Pink Floyd, infatti, usarono in questa circostanza le tecnologie più avanzate dell'epoca, come la registrazione multi traccia, i nastri magnetici in loop, i sintetizzatori analogici e introdussoro rumori d'ambiente. Gli effetti sonori dell’intero LP furono curati da Alan Parson, geniale precursore delle dissonanze elettroniche. Le parti strumentali, solitamente lunghe nelle precedenti opere, vennero ridotte per lasciare più spazio ai testi, tutti scritti da Roger Waters, in modo da prendere in esame i diversi temi che sfuggono al controllo razionale dell’uomo, entrando così a far parte del “lato oscuro della luna”. La scelta del brano è stata determinata sia dalla ricchezza delle dissonanze musicali e sia dal testo. Money, infatti, esaminò il lato oscuro del denaro e del consumismo, divenendo parte integrante di quel messaggio culturale ambientalista e anticonsumista che tanto ha influito sull’esplorazione delle dissonanze enologiche, che i vignaioli “naturali” hanno percorso negli anni che seguirono.
Money disco, qui invece nella versione originale registrata in studio.
The Dark Side of the Moon, con oltre quarantacinque milioni di copie, è il quarto disco più venduto di sempre. Nacque, in parte, durante il tour di presentazione di Meedle del 1971, fu perfezionato nel corso dell’omonimo tour, che debuttò al Rainbow Theatre di Londra il 17 gennaio del 1972. L’album fu infine registrato in due sessioni nel 1972 e nel 1973, agli Abbey Road Studios di Londra, e rappresenta l’apice della sperimentazione del gruppo. I Pink Floyd, infatti, usarono in questa circostanza le tecnologie più avanzate dell'epoca, come la registrazione multi traccia, i nastri magnetici in loop, i sintetizzatori analogici e introdussoro rumori d'ambiente. Gli effetti sonori dell’intero LP furono curati da Alan Parson, geniale precursore delle dissonanze elettroniche. Le parti strumentali, solitamente lunghe nelle precedenti opere, vennero ridotte per lasciare più spazio ai testi, tutti scritti da Roger Waters, in modo da prendere in esame i diversi temi che sfuggono al controllo razionale dell’uomo, entrando così a far parte del “lato oscuro della luna”. La scelta del brano è stata determinata sia dalla ricchezza delle dissonanze musicali e sia dal testo. Money, infatti, esaminò il lato oscuro del denaro e del consumismo, divenendo parte integrante di quel messaggio culturale ambientalista e anticonsumista che tanto ha influito sull’esplorazione delle dissonanze enologiche, che i vignaioli “naturali” hanno percorso negli anni che seguirono.
Money Live
Money Disco

Money, get away
Get a good job with more pay and you're okay
Money, it's a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream
Think I'll buy me a football team
Money, get back
I'm all right Jack keep your hands off of my stack
Money, it's a hit
Don't give me that do goody good bullshit
I'm in the high-fidelity first class traveling set
And I think I need a Lear jet
Money, it's a crime
Share it fairly but don't take a slice of my pie
Money, so they say
Is the root of all evil today
But if you ask for payrise it's no surprise
That they're giving none away
Away, away, way
Away, away, away

Denaro, vai via
trova un buon lavoro più pagato e sei a posto
Denaro, è un gas
Prendi quei contanti con entrambe le mani e mettili da parte
Una nuova macchina, caviale, illusioni a 4 stelle
Penso di comprarmi una squadra di calcio
Denaro, ritorna
Sto bene, Jack, togli le mani dal mio gruzzolo
Denaro, è il top
Non rifilarmi fesserie da due soldi
Io sono tra i fedelissimi della prima classe
E penso di meritarmi un jet privato
Denaro, è un crimine
Dividetelo equamente ma non toccate la mia fetta di torta
Denaro, dicono
sia l’origine di tutti i mali
Ma se chiedi un aumento non è una sorpresa
Se non ti regaleranno nulla
Lontano, lontano, via
Lontano, lontano, lontano
 Il produttore di vino doveva presentare caratteristiche simili: voglia di sperimentare cose nuove senza timore di esprimere quelle dissonanze che il vino tende naturalmente a produrre. Nello stesso tempo serviva un produttore di provata esperienza che assicurasse la mancanza di giovanili eccessi, che mal si sarebbero abbinati con il brano scelto. Chi meglio quindi di Josko Gravner, che oltre a predicare l’assoluto rispetto per l’ambiente, ha deciso ben venti anni orsono di recuperare l’anfora, di caucasica memoria, come strumento di vinificazione. Eretico alchimista, Gravner ha esplorato tanto e a modo suo: prima il convenzionale con fermentazioni in barriques, abbandonate, insieme all’acciaio, in favore della terracotta; della biodinamica ha fatto suo il calendario lunare di Maria Thun, che ogni hanno fornisce informazioni sul momento migliore per operare gli interventi in vigna e le lavorazioni in cantina. Il sovescio è, insieme alla costruzione di piccoli stagni artificiali internamente ai vigneti più grandi, il sistema per ricostituire la micro fauna e la flora di terreni sfibrati da coltivazioni intensive. Dal biologico ha preso i fitofarmaci consentiti, mentre in cantina regnano i lieviti indigeni e il minimalismo interventista con la solforosa ai minimi termini. È impossibile, quindi, chiudere Gravner in uno schema o in una certificazione, così come è impossibile chiudere i suoi vini in una scala timbrica melodica. L’armonia, in essi, si forma per vie molto più complesse, in cui le dissonanze diventano fonte di espressione mai scontata. La loro geniale follia è stata paragonata ai computer di Steve Jobs, al pianoforte di Keith Jarrett, alla cinepresa di Kubrick, per me sono, invece, espressioni uniche e irripetibili, e per questo motivo sono molto imitate, spesso con poco successo. Per l’esperimento di abbinamento propendo per il Breg Anfora 2002, un blend composto in prevalenza da Sauvignon e Pinot Grigio, con quote minoritarie di Chardonnay e Riesling Italico. Come la musica, pur avendo molti anni sulle spalle è un vino di impressionante attualità. Al colore ricorda l’ambra baltica, ricca di inclusioni che ne fanno virare il colore verso l’arancio, facendo presagire indecifrabili sensazioni olfattive. Mentre osservo il vino, mi giungono all’orecchio i ticchettii del vecchio registratore di cassa e delle monete, che costituiscono il preludio di Money. Il tempo anomalo e l’arpeggio del basso di Roger Waters creano il contrappunto cui fanno eco nel bicchiere le dissonanze ossidative e quella di una leggiadra volatile. Dietro di esse, al naso, le intense sensazioni minerali e note floreali e fruttate, misteriosamente fresche, giungono in perfetta sintonia con l’ingresso di chitarra e tastiere. La voce di David Gilmour sembra chiudere il complesso quadro armonico così come sfumature di erbe aromatiche completano quello olfattivo. Il riff di tutti gli strumenti si ripete per due strofe dando struttura al componimento musicale, così come intatta freschezza e matura morbidezza la conferiscono al sorso. Una sferzata viene data dall’entrata in assolo del sax che vibra sulla irregolare base ritmica, cui corrisponde in bocca quel velato supporto volatile che, in perfetto equilibrio, sembra armonizzare la complessa dinamica gustativa. Dinamica, questa, che si articola, dopo l’uscita di scena del sax e lo stacco di batteria, sul lungo dialogo che la chitarra solista sviluppa con la nuova e serrata base ritmica. Gli effluvi di carsica mineralità perfettamente integrati, guidano il ritorno al ritmo irregolare del riff iniziale che sfuma leggiadro nel finale. Al gusto, così come all’udito, le dissonanze, lungi dall’essere circondate da consonanze non troppo dissimili, esprimono tutte le loro potenzialità acquisendo una maggiore ricchezza polifonica che conduce away, away, away…
Il produttore di vino doveva presentare caratteristiche simili: voglia di sperimentare cose nuove senza timore di esprimere quelle dissonanze che il vino tende naturalmente a produrre. Nello stesso tempo serviva un produttore di provata esperienza che assicurasse la mancanza di giovanili eccessi, che mal si sarebbero abbinati con il brano scelto. Chi meglio quindi di Josko Gravner, che oltre a predicare l’assoluto rispetto per l’ambiente, ha deciso ben venti anni orsono di recuperare l’anfora, di caucasica memoria, come strumento di vinificazione. Eretico alchimista, Gravner ha esplorato tanto e a modo suo: prima il convenzionale con fermentazioni in barriques, abbandonate, insieme all’acciaio, in favore della terracotta; della biodinamica ha fatto suo il calendario lunare di Maria Thun, che ogni hanno fornisce informazioni sul momento migliore per operare gli interventi in vigna e le lavorazioni in cantina. Il sovescio è, insieme alla costruzione di piccoli stagni artificiali internamente ai vigneti più grandi, il sistema per ricostituire la micro fauna e la flora di terreni sfibrati da coltivazioni intensive. Dal biologico ha preso i fitofarmaci consentiti, mentre in cantina regnano i lieviti indigeni e il minimalismo interventista con la solforosa ai minimi termini. È impossibile, quindi, chiudere Gravner in uno schema o in una certificazione, così come è impossibile chiudere i suoi vini in una scala timbrica melodica. L’armonia, in essi, si forma per vie molto più complesse, in cui le dissonanze diventano fonte di espressione mai scontata. La loro geniale follia è stata paragonata ai computer di Steve Jobs, al pianoforte di Keith Jarrett, alla cinepresa di Kubrick, per me sono, invece, espressioni uniche e irripetibili, e per questo motivo sono molto imitate, spesso con poco successo. Per l’esperimento di abbinamento propendo per il Breg Anfora 2002, un blend composto in prevalenza da Sauvignon e Pinot Grigio, con quote minoritarie di Chardonnay e Riesling Italico. Come la musica, pur avendo molti anni sulle spalle è un vino di impressionante attualità. Al colore ricorda l’ambra baltica, ricca di inclusioni che ne fanno virare il colore verso l’arancio, facendo presagire indecifrabili sensazioni olfattive. Mentre osservo il vino, mi giungono all’orecchio i ticchettii del vecchio registratore di cassa e delle monete, che costituiscono il preludio di Money. Il tempo anomalo e l’arpeggio del basso di Roger Waters creano il contrappunto cui fanno eco nel bicchiere le dissonanze ossidative e quella di una leggiadra volatile. Dietro di esse, al naso, le intense sensazioni minerali e note floreali e fruttate, misteriosamente fresche, giungono in perfetta sintonia con l’ingresso di chitarra e tastiere. La voce di David Gilmour sembra chiudere il complesso quadro armonico così come sfumature di erbe aromatiche completano quello olfattivo. Il riff di tutti gli strumenti si ripete per due strofe dando struttura al componimento musicale, così come intatta freschezza e matura morbidezza la conferiscono al sorso. Una sferzata viene data dall’entrata in assolo del sax che vibra sulla irregolare base ritmica, cui corrisponde in bocca quel velato supporto volatile che, in perfetto equilibrio, sembra armonizzare la complessa dinamica gustativa. Dinamica, questa, che si articola, dopo l’uscita di scena del sax e lo stacco di batteria, sul lungo dialogo che la chitarra solista sviluppa con la nuova e serrata base ritmica. Gli effluvi di carsica mineralità perfettamente integrati, guidano il ritorno al ritmo irregolare del riff iniziale che sfuma leggiadro nel finale. Al gusto, così come all’udito, le dissonanze, lungi dall’essere circondate da consonanze non troppo dissimili, esprimono tutte le loro potenzialità acquisendo una maggiore ricchezza polifonica che conduce away, away, away…